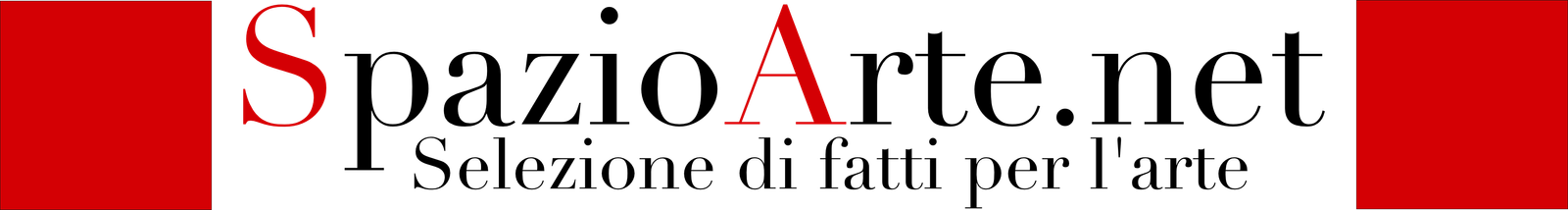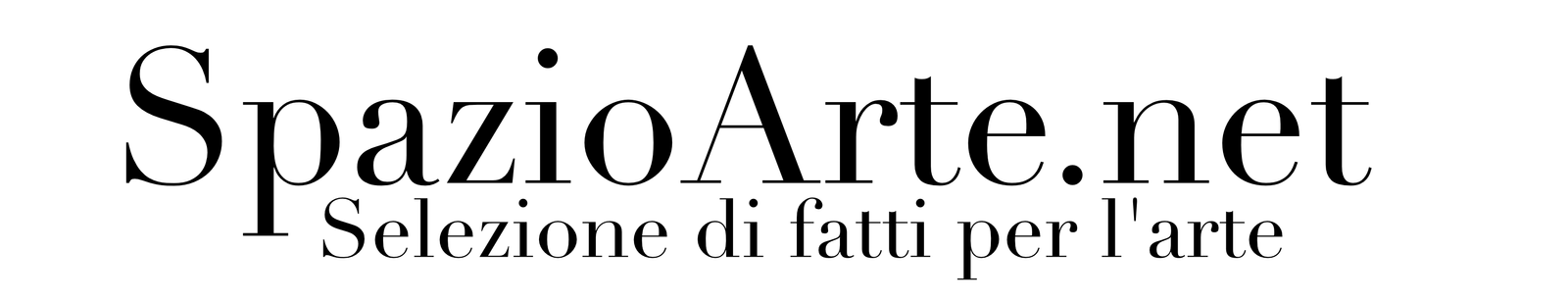Francesco: il Papa che ha fatto politica con il Vangelo pensando agli ultimi Quando Jorge Mario Bergoglio si affacciò per la prima volta dalla loggia di San Pietro, la sera del 13 marzo 2013, disse con un sorriso disarmante che i suoi fratelli cardinali erano andati a prenderlo “quasi alla fine del mondo”. Un’espressione semplice, quasi ingenua, eppure potentemente politica. Perché con Francesco, il primo papa gesuita e il primo latinoamericano, la Chiesa cattolica è tornata al centro del discorso globale. E non solo spirituale. La sua elezione è un evento inedito sotto ogni punto di vista. Avviene non dopo la morte del predecessore, ma dopo le storiche dimissioni di Benedetto XVI. Per la prima volta dopo secoli, due papi vivono insieme nel cuore del Vaticano. Una situazione senza precedenti, che dà immediatamente la misura di un pontificato destinato a rompere schemi. Francesco eredita una Chiesa scossa da scandali, divisa, in crisi di vocazioni e credibilità. Ma anziché rifugiarsi nella prudenza diplomatica, imprime una direzione chiara: povertà, inclusione, pace. Il suo primo viaggio è a Lampedusa, simbolo delle tragedie migratorie nel Mediterraneo. Lì non pronuncia un discorso ecclesiale, ma un atto di accusa: “Ho sentito che dovevo venire qui a pregare, ma anche a risvegliare le coscienze”. Il Papa parla, ma soprattutto agisce da leader globale, usando la forza morale del suo ruolo per incidere sulla realtà. Con lui, il Vaticano torna a essere un attore politico internazionale, ma con un linguaggio nuovo. La Laudato si’, la sua enciclica sul clima e l’ambiente, è un testo politico travestito da meditazione spirituale. La denuncia dell’economia dello scarto, della finanza speculativa, della distruzione della casa comune, lo avvicina più a Greta Thunberg che a certi vescovi conservatori. Non a caso, nei sacri palazzi cominciano a chiamarlo, con fastidio malcelato, “il papa comunista”. La sua azione geopolitica è continua e scomoda. Parla contro la guerra, senza ambiguità. Denuncia i produttori di armi, le complicità dell’Occidente, la retorica bellicista. Sulla guerra in Ucraina rifiuta di schierarsi in modo binario. Viene criticato per non nominare la Russia come aggressore, ma ribadisce: “È più coraggioso chi alza la bandiera bianca”. Una frase che fa esplodere polemiche, ma che resta coerente con la sua visione evangelica del disarmo totale. Un pacifismo radicale, poco gradito alle cancellerie, ma instancabile. Francesco parla ai migranti, agli esclusi, ai giovani, agli ecologisti, ai non credenti, più che a parte della sua stessa gerarchia. La sua figura sfugge alla definizione tradizionale di papa. È, piuttosto, un leader morale globale che entra nel dibattito culturale e politico con parole e gesti che scavalcano confini e dottrine. E tuttavia, se l’impatto politico è evidente, la riforma interna della Chiesa resta incompiuta. Sui temi del celibato, delle donne, dell’omosessualità, dell’aborto, Francesco apre dibattiti, cambia il tono, ma non la sostanza. Le sue frasi, come “Chi sono io per giudicare?”, aprono spazi di comprensione, ma non si traducono in cambiamenti dottrinali concreti. È il limite e forse anche la misura del suo pontificato: riformista nel linguaggio, prudente nella struttura. Negli ultimi anni, la salute lo mette alla prova. La scena simbolica della pandemia – la sua figura curva, sola, in una Piazza San Pietro deserta – lo consacra come guida spirituale del mondo nel buio. Poi i ricoveri, la voce affaticata, le dimissioni annunciate e il ritorno, come Benedetto, in Vaticano. Il suo ultimo messaggio, a Pasqua, è l’ennesimo atto politico: “Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo.” Non una benedizione convenzionale, ma un monito alla comunità internazionale. In un mondo attraversato da nuove guerre, crisi climatiche, disuguaglianze crescenti, Francesco lascia la scena come l’ha vissuta: non da sovrano, ma da coscienza inquieta. Con lui si chiude una stagione della Chiesa, ma soprattutto un ciclo del cattolicesimo come forza pubblica globale. Ora la domanda che resta è eminentemente politica: la Chiesa continuerà a essere voce di pace e giustizia, o tornerà a rifugiarsi nel silenzio delle sacrestie? Francesco, venuto dalla fine del mondo, ha portato nel cuore di Roma la voce degli invisibili. E ha ricordato al potere – laico o ecclesiastico – che il Vangelo può ancora essere una bandiera.
La pace fa paura ai vigliacchi
La pace fa paura ai vigliacchi di Luciano Di Gregorio C’è una verità che nessuno osa pronunciare: la pace fa paura. Fa paura ai governi, ai generali, ai giornalisti embedded, ai venditori di armi e agli opinionisti che si sono scoperti strateghe militari con l’abbonamento al Corriere. La pace fa paura perché è una smentita. E le smentite, si sa, costano carriere, reputazioni e contratti da consulenza. Questa guerra non doveva finire. Doveva diventare struttura. Rumore di fondo. Una colonna sonora di droni e sanzioni per accompagnare le giornate dei cittadini occidentali, mentre nel backstage si costruiva un nuovo ordine mondiale, con la NATO come regista e l’Europa come controfigura. E invece, come in ogni tragedia greca, arriva il personaggio imprevedibile: Donald Trump. Uno che non ha bisogno di risultare coerente, ma solo inevitabile. Entra in scena, dice che la guerra è persa, che l’Ucraina è stata usata, che i valori occidentali sono etichette con il prezzo sopra. E il cast istituzionale va in panico, come attori incapaci davanti a un improvvisatore geniale. Il grande inganno Abbiamo vissuto tre anni dentro una favola bellica scritta da sceneggiatori falliti: Putin era Hitler, Zelensky Churchill, la NATO la Croce Rossa. Il risultato? Mezzo milione di morti, un paese devastato, un’Europa più povera, e una Russia ancora lì. Ci avevano detto: “Putin è finito”. “La Russia fallirà”. “Le sanzioni funzionano”. “È una guerra per la democrazia”. “Non daremo armi offensive”. “Non useremo bombe a grappolo”. “Non manderemo truppe”. Ogni frase è stata smentita dai fatti. E ogni smentita è stata coperta da una nuova bugia. Chi ha cercato di dire la verità è stato etichettato: putiniano, pacifinto, traditore, disertore morale. Perché in un’epoca di guerra totale, anche il pensiero è un campo minato. Ma ora che la narrazione si sfalda, che resta? Restano i rottami morali di chi ha tifato per il conflitto, con la foga dei miserabili che scambiano la guerra per riscatto. Restano i bilanci: umani, economici, politici. E restano i cittadini, da soli, con le tasche vuote e le scorte di aspirine nelle “borse della resilienza”. L’Europa senza dignità L’Unione Europea, in questa storia, si è giocata tutto: autorità, credibilità, senso. Ha trasformato la parola “pace” in un imbarazzo diplomatico. Ha delegato agli americani ogni decisione strategica, e ora piagnucola perché Trump tratta con Putin. Ma cosa pretendevamo? Che i due imperi si scannassero per farci contenti? Che gli ucraini morissero in eterno per la nostra coerenza narrativa? L’unica coerenza europea è stata l’obbedienza. Anche al ridicolo. Siamo stati capaci di approvare un riarmo da 800 miliardi chiamandolo “prontezza 2030”. Cioè: ci armiamo oggi per essere pronti tra cinque anni. Come dire a un ladro: entra pure, fra un lustro ti arrestiamo. I nuovi Tafazzi I veri responsabili del disastro non sono i falchi americani, né i russi, né i trumpiani. Sono i tafazzi nostrani: quella classe politica, mediatica e intellettuale che ha spinto per la guerra senza sapere perché, che ha fatto il tifo per le armi con lo stesso entusiasmo con cui prima si entusiasmava per i vaccini, i selfie e gli NFT. Sono quelli che ti dicevano: “La pace si fa solo dopo la vittoria.” Come se nella storia le guerre fossero finite tutte con un trofeo e una stretta di mano. La pace si fa quando si può, non quando è comoda. E ora, davanti all’ipotesi di un negoziato vero, questi signori impazziscono. Perché se la pace arriva, la loro narrativa crolla. E con essa, la loro carriera. Per questo si inventano nuove minacce: Putin vuole Lisbona, la NATO è scomparsa, la Germania è un pericolo, la Russia è immortale, ma anche allo stremo. Non hanno più logica. Hanno solo paura. La guerra è finita. Il teatrino no. Questa guerra è finita. Non ufficialmente, ma nella sostanza. È finita perché il suo scopo era altro: ridisegnare gli equilibri globali, drenare risorse europee, testare la lealtà atlantica. L’Ucraina è stata il pretesto. Il campo da gioco. Non il fine. La pace ora si può fare. Forse non sarà “giusta”, forse non sarà “pura”. Ma sarà reale. E ogni giorno che passa, ogni morto in più, è colpa di chi non la vuole. E chi non la vuole, oggi, è il vero nemico.